La storiografia di Gioacchino Volpe, contrariamente ad un’ancora corrente vulgata, è saldamente radicata sul primato della sfera sociale su quella politica e dunque della politica interna su quella estera. Da una letteratura superficiale della sua opera potrebbe parere adeguato servirsi, per definirla, delle stesse parole che Ernesto Ragionieri utilizzava per descrivere la Storia dei popoli di lingua inglese di Winston Churchill, riducendola giustamente a un “tracciato tutto fondato sulla convinzione che frontiere, razze, patriottismo e guerre costituiscano le verità ultime e fondamentali della storia del genere umano”. Impostazione, questa, che faceva fondamentalmente dell’analista del passato “uno storico dell’attività politica e dello Stato come espressione di forza e di potenza”.
Per molto, troppo tempo, anche il percorso intellettuale del maggior storico italiano della prima metà del Novecento è stato considerato, in termini di “storia-battaglia”, “storia-diplomazia”, “storia-Stato”, all’interno del quale emergeva in maniera preponderante, se non addirittura esclusiva, il ruolo dell’organizzazione politica e la sua aggressiva proiezione sul piano internazionale. Quest’interpretazione, per qualche verso non è infondata. Ma isolata da un contesto problematico più ampio, non esaurisce il senso più profondo del lavoro di Volpe. Anzi lo depotenzia e lo limita profondamente.
Per Volpe, infatti, la storia nazionale è in primo luogo “storia interiore” di un popolo, che trova la sua genesi nella sua istintiva organizzazione sociale, poi economica, in seguito giuridica e, solo alla fine, politica. In questa concezione era sicuramente presente la lezione di Otto von Gierke e di Pasquale Villari, secondo i quali la polarità tra Stato e società andava tutta risolta a favore del secondo termine, risiedendo la dimensione giuridica pubblica assai più nel corpo sociale che nell’architettura istituzionale ed essendo la costituzione politica, in definitiva, una semplice conseguenza della dinamica associativa dei gruppi privati.
Passando dal suo impegno di storico medievista a quello d’interprete della storia dell’Italia contemporanea, Volpe non abbandonava il senso profondo di questa narrazione, ma anzi lo arricchiva e lo rafforzava. Da un lato, egli rigettava la contrapposizione tra Risorgimento e storia unitaria che era stata accentuata dall’agiografia risorgimentista e approfondita dalla svalutazione nazionalistica della stagione successiva all’unificazione, intesa come epoca di decadenza rispetto al “miracolo italiano” del 1860. Dall’altro, tuttavia, proprio il Risorgimento gli appariva come un evento dipendente dalla congiuntura internazionale più che come momento di libera espansione degli “spiriti vitali” della Nazione, e soprattutto egli ne poneva in primo piano il carattere di opera di una minoranza che riuscì solo a creare un sottile tessuto connettivo tra i frammenti di un Paese profondamente diverso e sostanzialmente disunito nelle sue regioni e i suoi strati sociali.
Di conseguenza, il cammino della storia italiana non poteva non apparirgli, come scrisse nell’introduzione di “Italia moderna”, pubblicata tra 1943 e 1953, ostacolato da una criticità profonda e di ardua e complessa risoluzione. Per Volpe, dopo il 1861, l’Italia doveva risolvere, infatti, un problema di maturazione complessiva, di “formazione di un popolo”, per cui la super-struttura politico-amministrativa doveva impegnarsi ad aderire alla realtà sociale, acquistando quella concretezza, quel carattere proprio e nazionale, “quella storicità che in origine non possedeva”. E ciò era indispensabile per fare in modo che il corpo vivo della Nazione si elevasse, si arricchisse, agisse proprio su quella super-struttura politico-amministrativa, conformasse sé a essa ed essa a sé.
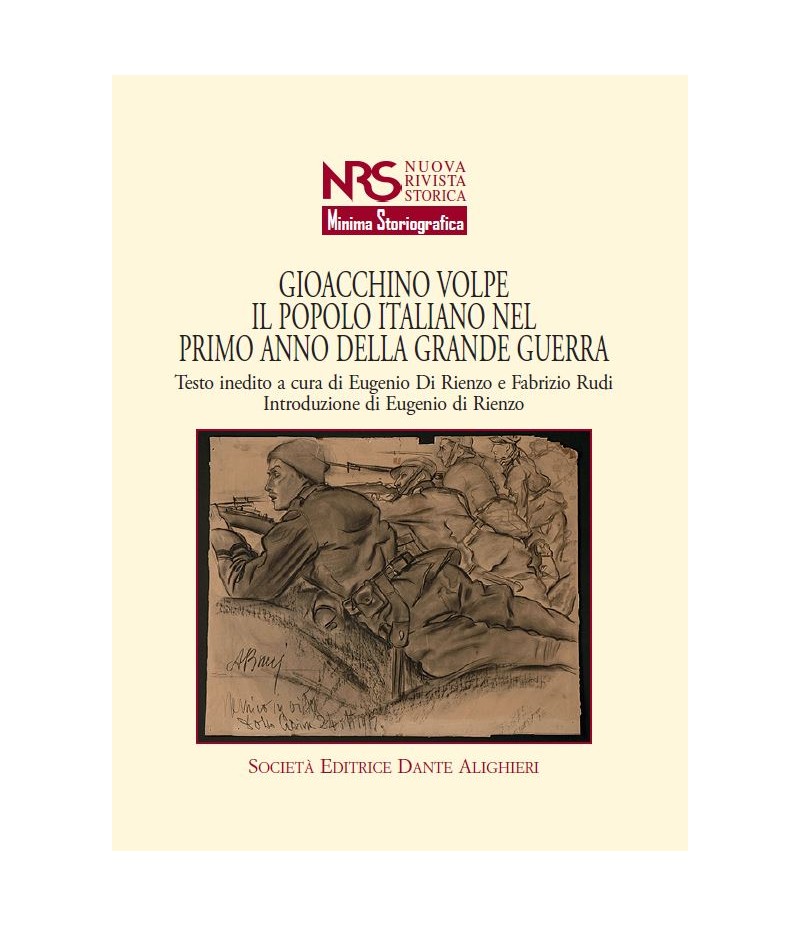
Il tentativo di analizzare questo complesso processo, inteso come “sviluppo completo di forze che progressivamente si organizzano e acquistano coscienza di sé sul terreno politico-sociale”, si ritrova nel manoscritto inedito di Volpe, “Il popolo italiano nel primo anno della Grande Guerra”, ora pubblicato per la cura di Eugenio Di Rienzo e Fabrizio Rudi, nella collana “Biblioteca della Nuova Rivista Storica”, edita dalla società editrice Dante Alighieri. Come scrive Di Rienzo nella corposa edizione, di oltre 150 pagine, in questo scritto, la cui composizione risale ai primi mesi del 1943, Volpe si dimostra veramente non storico “nazional-populista” (come forse ancora oggi altri direbbero) ma “storico nazional-popolare”, a parte intera. Il fuoco di questo lavoro si concentra, infatti, sulla “storia civile, interna del popolo italiano durante la guerra”. Da questa visione, nascono le pagine dedicate al successo della mobilitazione industriale, al ruolo non secondario svolto in essa dal genere femminile, al fenomeno del vario volontariato militare, alla presenza rilevante della nostra emigrazione nello sforzo bellico, alla capacità della società italiana tutta, intellettuali in prima linea, di affiancarsi al popolo in grigioverde che si batteva sul Carso e sul fronte alpino, per passare l’”esame di riparazione” indispensabile per riscattare l’onta di Custoza, Lissa e Adua. E da questa visione ancora prende origine la commossa forza rievocativa, con cui la storia non parla solo alla ragione indagatrice ma anche al sentimento morale, dell’analisi dedicata alle sofferenze e ai travagli (esodi forzati, internamenti, violenze, malattie, denutrizione), di cui furono vittime, donne, minorenni, anziani, disabili. Martiri senza colpa, i quali si ritrovarono coinvolti in un conflitto totale e globale che, forse per la prima volta, fu, in maniera tanto spietata, anche “guerra contro i civili”.



