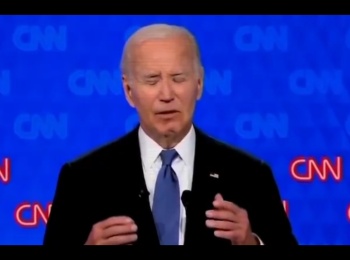“Obamagate makes Watergate look small time!”, il Watergate è poca cosa in confronto all’Obamagate. “Il più grande crimine politico della storia americana”, un crimine “molto grave”. I roboanti tweet del presidente Trump di ieri e dei giorni scorsi aprono di fatto quello che lui stesso ha ribattezzato “Obamagate” e sembrano suggerire che l’inchiesta del procuratore Durham sulle origini dell’indagine di controintelligence sulla presunta collusione con la Russia stia puntando al bersaglio più grosso: l’ex presidente Obama.
Sui media italiani, gli stessi che per mesi hanno cavalcato e fatto da megafono alla bufala del Russiagate, è probabile che non leggerete e non sentirete nulla di quanto sta accadendo in questi giorni a Washington.
Ma come si è arrivati al coinvolgimento dell’ex presidente Obama in quello che l’Attorney General William Barr ha di recente definito “un intero schema di eventi per sabotare la presidenza Trump”? Da un passaggio della testimonianza declassificata dell’ex vice procuratore generale Sally Yates, che abbiamo riportato già la scorsa settimana. La vice AG dichiarò al team del procuratore speciale Mueller di aver appreso delle telefonate di dicembre tra il generale Flynn (consigliere per la sicurezza nazionale entrante) e Kislyak (l’ambasciatore russo a Washington), e del loro contenuto, sanzioni comprese, dal presidente Obama in persona, al termine di una riunione nello Studio Ovale il 5 gennaio 2017, sullo scadere quindi della transizione tra le due amministrazioni, e di esserne rimasta “sorpresa”. Presenti anche il vicepresidente Biden, il direttore dell’FBI Comey e il consigliere per la sicurezza nazionale Susan Rice. L’incontro seguiva una riunione più allargata con tutti i vertici della comunità di intelligence Usa (Brennan della CIA e il DNI Clapper) che aveva come oggetto la valutazione sulle interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali appena tenutesi con l’esito che sappiamo. Dell’indagine su Flynn e delle sue telefonate con Kislyak si parlò anche nella riunione allargata precedente?
Dalle audizioni a porte chiuse della Commissione Intelligence della Camera declassificate la scorsa settimana (57 in tutto tra 2017 e 2018, 6.000 pagine) sappiamo che l’allora direttore dell’Intelligence Nazionale, James Clapper, testimoniò a luglio del 2017 di non aver mai informato il presidente Obama dell’oggetto di quelle conversazioni. Ma durante la sua audizione del 2 marzo, il direttore dell’FBI Comey aveva dichiarato che fu proprio Clapper ad informare il presidente prima dell’incontro nello Studio Ovale con Rice, Comey e Sally Yates.
Le identità dei funzionari dell’amministrazione Obama che erano a conoscenza delle chiamate tra Flynn e Kislyak sono diventate uno snodo chiave nell’indagine del procuratore Durham. Il nome di Flynn e i contenuti dei suoi colloqui con Kislyak erano informazioni classificate ai massimi livelli, eppure furono passate al Washington Post all’inizio di gennaio per creare un pretesto affinché l’FBI interrogasse Flynn. Un grave illecito. Di ieri la notizia che l’attuale direttore dell’Intelligence Nazionale, Richard Grenell, ha autorizzato la declassificazione dei nomi dei funzionari autorizzati a conoscere l’identità di Flynn nelle trascrizioni delle intercettazioni.
Ora sappiamo, dalle note del capo della controintelligence Bill Priestap, che abbiamo già riportato, dagli altri documenti di recente declassificati e dalla richiesta del Dipartimento di Giustizia di lasciar cadere le accuse contro Flynn, che in quelle conversazioni telefoniche non c’era nulla di inappropriato, che l’FBI già il 4 gennaio era pronta a chiudere l’indagine, ma che al 7° piano dell’agenzia (direttore e vice) decisero di tenerla aperta e di interrogare, pur senza basi investigative legittime, il primo consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, per indurlo in errore così da poterlo incriminare o farlo licenziare. In una parola, una trappola, che avrebbe letteralmente fatto esplodere il Russiagate.
Due giorni dopo l’interrogatorio del 24 gennaio, Sally Yates, in quel momento procuratore generale ad interim, utilizzò quelle trascrizioni per cercare di far licenziare Flynn, avvertendo la Casa Bianca che il neo consigliere si era “compromesso” con una falsa dichiarazione ed era “vulnerabile” ai ricatti russi. Cosa che sapeva benissimo essere falsa.
Ma la versione della Yates, non smentita, indica che almeno dal 5 gennaio il presidente Obama era a conoscenza dell’indagine e del contenuto delle telefonate, e mostra come il direttore Comey abbia volutamente aggirato il Dipartimento di Giustizia e ignorato la vice procuratore generale. Il team Durham starebbe indagando per verificare i sospetti dei legali di Flynn, secondo i quali fu proprio Obama a ordinare a Comey e alla Yates di continuare l’indagine sul generale, sul presupposto della violazione del Logan Act, proprio durante l’incontro del 5 gennaio. Sulla base evidentemente di una motivazione politica, dato che elementi a suo carico non erano emersi, nemmeno nelle telefonate con Kislyak, e l’indagine era già praticamente chiusa dal giorno prima. Insomma, sarebbe stato Obama il vero architetto del Russiagate.
C’è anche una prova “logica”. Nelle dichiarazioni del vice direttore McCabe e del capo della controintelligence Priestap, la decisione dell’FBI di non procedere con un “briefing difensivo” al candidato Trump sul rischio che qualcuno della sua squadra stesse colludendo con la Russia viene sempre motivata con il fatto che all’epoca non sapevano esattamente chi della Campagna fosse coinvolto con i russi e non volevano pregiudicare l’indagine influenzando il comportamento dei sospettati. Ci sta. La motivazione però non regge più all’indomani dell’elezione di Trump, dal momento che l’FBI aveva ormai individuato quattro persone, tra cui il generale Flynn, su cui concentrare le proprie indagini in altrettanti filoni dell’inchiesta Crossfire Hurricane. Eppure, ancora nessun “briefing difensivo” a colui che era nel frattempo diventato il presidente eletto.
Quindi arriva l’incontro del 5 gennaio. Nei suoi appunti, l’allora consigliere per la sicurezza nazionale Susan Rice ricorda che “dal punto di vista della sicurezza nazionale, il presidente Obama ha affermato di voler essere sicuro che, mentre ci impegniamo con la squadra entrante, siamo attenti nell’accertare se c’è qualche motivo per cui non possiamo condividere completamente le informazioni per quanto riguarda la Russia”. Inoltre, scrive la Rice, “il presidente ha chiesto a Comey di informarlo di qualsiasi sviluppo nelle prossime settimane che dovrebbe influenzare il modo in cui condividiamo informazioni classificate con la squadra entrante”. E il direttore dell’FBI eseguirà l’ordine.
Obama sapeva che il presidente Trump avrebbe nominato Flynn consigliere per la sicurezza nazionale. E sapeva che era in corso un’indagine dell’FBI su Flynn, sull’ipotesi che collaborasse con la Russia. Eppure, ordinò ai suoi di non metterne al corrente il presidente eletto.
Anche dopo l’insediamento della nuova amministrazione, Comey ha continuato a seguire il suggerimento di Obama non informando Trump e, anzi, violando prassi e protocolli il 24 gennaio ha mandato i suoi agenti alla Casa Bianca per interrogare Flynn.
Delle due l’una, come ha osservato Margot Cleveland di The Federalist, o il presidente Obama voleva lasciare un sospetto “agente russo” alla Casa Bianca, o sapeva che l’intera indagine era una bufala, una montatura.
In effetti, le impronte di Obama sulla campagna di sabotaggio (e spionaggio) ai danni del team del presidente eletto erano già evidenti nel marzo 2017, quando scrissi questo articolo.
Solo sette giorni prima di andarsene, come riportava Usa Today, l’allora presidente modificò la linea di successione al Dipartimento di Giustizia in modo che un suo uomo si trovasse a supervisionare l’indagine sui legami Trump-Russia nel caso il nuovo Attorney General Sessions fosse stato costretto a ricusarsi (come poi è avvenuto). E come riportato dal New York Times, solo 14 giorni prima di lasciare, Obama aveva esteso i poteri della NSA (Executive Order 12333) per consentirle di condividere le trascrizioni delle “comunicazioni personali intercettate” con altre 16 agenzie federali (tra cui l’FBI) prima di applicare le restrizioni previste dalla tutela della privacy, in modo che funzionari a lui fedeli ovunque nell’amministrazione potessero più facilmente avere accesso, utilizzare, ed eventualmente passare alla stampa amica, passaggi attentamente selezionati. Lo stesso NYT riportava che negli ultimissimi giorni di presidenza Obama, alcuni funzionari della Casa Bianca si sono fatti in quattro per assicurarsi che le informazioni fossero preservate e diffuse il più possibile tra le agenzie governative, ad uso e consumo di eventuali ulteriori indagini e della stampa.
Ma nei giorni scorsi sono emersi ulteriori elementi rilevanti rispetto all’incontro del 5 gennaio nello Studio Ovale che chiama in causa l’ex presidente Obama.
Cosa è emerso dalle audizioni a porte chiuse dalla Commissione Intelligence della Camera? È emerso che proprio mentre era in corso l’inchiesta del procuratore speciale Mueller, e mentre i Democratici e la stampa liberal (e di mezzo mondo) alimentavano la narrazione del Russiagate fino alla procedura di impeachment, gli alti funzionari dell’amministrazione Obama, nel chiuso delle stanze della Commissione presieduta dal Democratico Adam Schiff, ammettevano di non aver visto “prove empiriche” di una collusione tra la Campagna Trump e la Russia. A cominciare dall’ex DNI James Clapper: “Non ho mai visto alcuna prova empirica diretta che la Campagna Trump o qualche suo associato stesse complottando o cospirando con i russi per interferire nelle elezioni”. Preoccupazioni sì, “prove aneddotiche”, ma niente di più. In questi termini anche l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Susan Rice, l’ex vice consigliere Ben Rhodes (“non ho visto prove specifiche”) e l’ex ambasciatrice all’Onu Samantha Power. Persino l’ex Attorney General Loretta Lynch, alle cui dipendenze era l’FBI, che indagava sulla Campagna Trump almeno dal 31 luglio 2016, se non da prima.
L’allora direttore ad interim dell’FBI, Andrew McCabe, ammetteva che il dossier Steele non era stato verificato. E oggi sappiamo dal rapporto Horowitz che fu l’elemento “essenziale” per ottenere, ingannando la Corte FISA, l’autorizzazione a sorvegliare Carter Page.
Ma c’è di più. Sempre in una di queste audizioni, John Podesta, il presidente della Campagna Clinton, ha ammesso che sia lui che la candidata Dem sapevano di aver commissionato la ricerca di materiale compromettente sui legami di Trump con la Russia. E ha ammesso che tramite lo studio legale Perkins Coie, il Comitato nazionale democratico e la Campagna Clinton si sono divisi fifty-fifty i costi della Fusion GPS e del dossier Steele, anche se ha precisato di averlo saputo dopo le elezioni e la sua prima testimonianza al Senato. Il legale della Campagna Clinton Marc Elias ha testimoniato di aver spedito il conto della Fusion al manager della Campagna, Robby Mook.
Importanti rivelazioni anche nella testimonianza declassificata di Michael Gaeta, l’agente dell’FBI che dall’ambasciata di Via Veneto, a Roma, gestiva la fonte Christopher Steele. Gaeta ha dichiarato di aver chiesto a Steele nel luglio 2016 “se il dossier non era verificato. Disse che non aveva alcuna conferma indipendente da altre fonti”. Eppure, Gaeta inoltrò il dossier ai piani alti dell’FBI. Tra luglio e ottobre 2016, furono sei i rapporti riguardanti Trump e la Russia che come informatore retribuito Steele ha passato all’FBI. Gaeta ha inoltre testimoniato di aver annotato in rapporti FD-1023 il suo primo incontro con Steele il 5 luglio 2016 (a Roma) e l’ultima conversazione, a novembre, ma l’ispettore generale Horowitz non ne ha menzionato alcuno nel suo rapporto. All’ex agente britannico la sede centrale dell’FBI accordò un lauto compenso, che gli fu offerto durante un altro incontro, il 3 ottobre, anche questo a Roma, con tre agenti del team che indagava sulla Campagna Trump. Circa un mese dopo, la chiusura formale del rapporto con Steele, dopo aver scoperto che stava diffondendo parti del dossier alla stampa e a mezza Washington.
Insomma, da prima dell’insediamento del presidente Trump alla Casa Bianca, l’FBI, il Dipartimento di Giustizia e i funzionari apicali dell’amministrazione Obama, sapevano tutti che non c’era alcun elemento concreto che provasse una collusione del team Trump con la Russia. Nulla era emerso su Flynn. Il dossier Steele era una bufala, che l’FBI sapeva – come accertato dall’ispettore Horowitz – essere non verificato, pagato dal Comitato nazionale democratico e dalla Campagna Clinton, nonché pieno di disinformazione russa. Anche il contatto Papadopoulos-Mifsud, usato per giustificare l’apertura dell’indagine Crossfire Hurricane il 31 luglio 2016, non aveva portato a nulla, come mostra il colloquio di fine ottobre 2016 con un informatore di recente declassificato. Eppure, i funzionari – ex o ancora in carica – fedeli a Obama inondavano di leaks la stampa liberal per alimentare la narrazione del Russiagate e delegittimare la presidenza, facendo credere che dalle indagini stavano emergendo tonnellate di prove, pur sapendo che era vero il contrario. Sulla base di questa montatura è stato nominato il procuratore speciale Mueller, il cui scopo era di porre le basi per l’impeachment, nel caso di maggioranza Dem anche al Senato, e il cover-up dell’indifendibile indagine di controintelligence condotta dall’FBI. “La vittoria di Donald Trump – sentenzia il board del Wall Street Journal – ha aumentato le possibilità che questo spionaggio senza precedenti su un avversario politico venisse scoperto, il che sarebbe stato per lo meno imbarazzante”. “Prendere di mira Flynn, e vendere lo screditato dossier Steele”, ha consentito di mantenere “bollente” il Russiagate e di aprire l’indagine Mueller, che dopo due anni “non ha prodotto prove di collusione”.