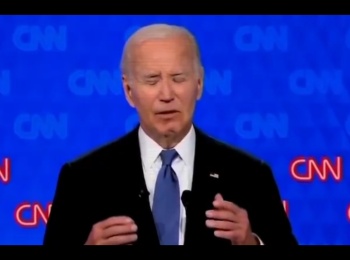In continuità con lo spirito di quelle precedenti, che ci hanno portato dove siamo, la riforma Cartabia si basa su una concezione della giustizia che affonda le sue radici nella mentalità “razionalista” (e non empirica) europeo-continentale, che subordina il ruolo e le funzioni delle varie parti del processo all’armonia dell’insieme e che in tal modo, anche senza averne l’espressa intenzione, da un lato attenua la posizione “paritaria” della difesa rispetto all’accusa, incidendo sulla libertà di imputati/indagati, dall’altro limita la separazione dei poteri tra pubblico ministero e giudice. Mentre è solo da una netta separazione della posizione e dei compiti istituzionali tra accusatore e giudice che deriva l’effettiva parità tra accusa e difesa, perché solo in tal modo il soggetto giudicante è pienamente “terzo” tra le parti, e solo se quest’ultimo è pienamente terzo la libertà del cittadino imputato o indagato è veramente tutelata
Se si esamina anche solo superficialmente il testo della legge di riforma del processo penale recentemente approvato dal Parlamento e frutto del lavoro di molti esperti, tra cui la stessa ministro Cartabia, che in parte entrerà in vigore immediatamente e in parte richiederà (come di solito avviene in queste materie) l’emanazione di una serie di decreti legislativi attuativi da parte del governo, risulta che essa si propone come obiettivo quello di creare un sistema giudiziario penale efficiente e, di conseguenza, più garantista verso i diritti delle persone coinvolte, in quanto indagate o formalmente imputate, nelle due fasi previste, cioè nelle indagini preliminari e nel processo penale vero e proprio. Si tratta di un duplice obiettivo decisamente lodevole che però come sempre in Italia viene stabilito “a tavolino” delineando un modello ideale ed astratto ed imponendo agli operatori di adeguarsi ad esso (di fatto, magari non in maniera assoluta, ma “tendenzialmente” nella misura maggiore possibile).
In questo senso anche nella riforma Cartabia si nota una continuità con lo spirito di quasi tutte quelle precedenti, a suo tempo elaborate da tecnici altrettanto preparati (si pensi solo alla redazione del codice di procedura penale del 1988), che però hanno portato alla situazione attuale, certo non invidiabile. Pur augurandoci che queste ultime modifiche normative determinino comunque un miglioramento concreto della realtà giudiziaria italiana (e saranno i fatti a dirlo), viene il dubbio che il difetto in gran parte stia nel manico, cioè nella pretesa di creare a priori, con pochi tratti di penna, un sistema armonico che garantisca tramite i meccanismi di legge una sorta di coordinazione e di mediazione tra l’azione “efficiente” dei soggetti pubblici (pubblico ministero e giudice) e la libertà dei cittadini indagati/imputati sostenuta dagli avvocati difensori. Si tratta di una concezione non solo italiana, ma tipica (sia pur con diverse sfumature) di tutti i Paesi europei continentali: una concezione che affonda le sue radici nella mentalità “razionalista” (e non empirica) che subordina il ruolo e le funzioni delle varie parti all’armonia dell’insieme e che in tal modo, anche senza averne l’espressa intenzione, da un lato attenua la posizione “paritaria” della difesa rispetto all’accusa, incidendo sulla libertà dei soggetti privati imputati/indagati, e dall’altro limita la separazione dei poteri tra pubblico ministero e giudice.
Un legame fondamentale quello tra separazione dei poteri e libertà individuale: dove la prima è incompleta anche la seconda è imperfetta, dato che solo con la contrapposizione tra i diversi rappresentanti dello stato (e non con la semplice distinzione dei compiti degli stessi in vista di una armonia collaborativa) il potere può limitare il potere e consentire ai cittadini di godere appieno degli spazi di libertà che una democrazia liberale dovrebbe loro riconoscere. Com’è noto queste cose le ha teorizzate quello che è stato forse l’unico tra i philosophes di cultura francese del 1700 a non essere legato al principio della ragione astratta come metro di giudizio della realtà e criterio di disciplina della società: Charles Secondat de Montesquieu (1689 – 1755), il quale basando le sue descrizioni su una analisi empirica delle diverse realtà storiche vedeva appunto nella contrapposizione tra i poteri statali l’unica garanzia per la libertà dei cittadini.
Tutto sommato il grande pensatore transalpino, che utilizzava come suo modello ideale il sistema costituzionale inglese, non si sarebbe troppo stupito nel vedere le sue idee incarnarsi non tanto in patria o nell’Europa continentale (dove alle stesse si fa un omaggio con il tempo divenuto quasi di facciata, che si accompagna sovente all’affermazione che sarebbero ormai “superate”), ma soprattutto nel sistema americano, che di quello inglese è l’erede. Non per nulla Montesquieu è l’autore più citato nella serie di articoli scritti in occasione dell’approvazione della Costituzione federale degli Stati Uniti che sono stati raccolti nel Federalista, il libro che ancora oggi costituisce il testo sacro del costituzionalismo americano nonché il punto di riferimento di molte sentenze in particolare della Corte suprema. In tutti i sistemi anglosassoni, e in quello americano in particolare, non è l’armonia dell’insieme stabilita a tavolino a definire le posizioni dei singoli, ma è la libertà di questi ultimi che crea l’insieme; non sono la giustizia e/o l’efficienza del processo che tutelano la libertà dell’imputato e stabiliscono i compiti dell’accusatore e del giudice, ma sono la contrapposizione tra le parti processuali e la definizione dei rispettivi ruoli in maniera “separata” che garantiscono le libertà dei cittadini imputati/indagati e in subordine ad essa la giustizia e l’efficienza del processo.
Nel processo penale europeo continentale, e in particolare in quello italiano, il pubblico ministero e il giudice rappresentano due funzionari pubblici che hanno uno scopo comune, quello di attuare la giustizia, applicando le norme penali al caso concreto, uno scopo che perseguono da punti di vista diversi, nettamente distinti, nel senso che il primo formula una richiesta di giudizio, che il secondo accoglie o meno (e che può anche ribaltare: per paradossale che possa sembrare, da noi il pubblico ministero può chiedere l’assoluzione e il giudice condannare), ma questa distinzione, se mi si passa il paragone è molto simile a quella che c’è nel processo di canonizzazione dei santi tra il postulatore della causa e quello che un tempo si chiamava l’avvocato del diavolo, due ruoli contrapposti, ma entrambi rivestiti da ecclesiastici il cui scopo comune è la verifica della santità di un determinato personaggio.
Una piena separazione dei poteri quale quella americana parte invece dal fatto che il pubblico ministero rientra a tutti gli effetti nel potere esecutivo, dato che la sua funzione è quella di far valere il diritto-dovere di quest’ultimo (in particolare degli organi di pubblica sicurezza e penitenziari) di applicare le sanzioni penali al presunto autore di un reato. Il suo compito primario non consiste quindi nel realizzare la giustizia e nemmeno nell’applicare la legge ma consiste nel far punire le persone ritenute colpevoli di reati: che lo possa e lo debba fare solo nei casi previsti dalle norme di legge costituisce un limite e una regola di azione fondamentale per il suo agire, ma non ne rappresenta lo scopo. Dal punto di vista americano sarebbe del tutto inconcepibile ad esempio che un pubblico ministero chiedesse al giudice di assolvere l’imputato, dato che gli basterebbe non esercitare l’azione penale.
Il giudice, a cui in America si affianca com’è noto una giuria “laica” del tutto autonoma (diversamente da quanto accade da noi dove, anche quando sono presenti, i giudici popolari hanno un ruolo subordinato rispetto ai togati) competente a dire la parola finale sulla colpevolezza dell’imputato, rientra invece ovviamente nel potere giudiziario, ma nemmeno per lui la mansione principale è quella di realizzare la giustizia o di attuare la legge: entrambe queste funzioni svolgono un ruolo essenzialmente strumentale e secondario rispetto al suo compito fondamentale, che consiste nel dare ragione all’accusa o alla difesa. In tale senso va compresa una delle più celebri (e spesso travisate) affermazioni di Montesquieu, secondo cui il potere giudiziario è un potere “nullo”, in quanto privo di una volontà propria: esso è tale dato che la sua decisione non ha un contenuto autonomo, ma consiste solo nell’accogliere, ovviamente secondo le regole del diritto, le richieste di una delle parti in causa, rigettando quelle dell’altra. Solo da questa netta separazione della posizione e dei compiti istituzionali tra accusatore e giudice deriva l’effettiva parità tra accusa e difesa, perché solo in tal modo il soggetto giudicante è pienamente “terzo” tra le parti, e solo se quest’ultimo è pienamente terzo la libertà del cittadino imputato o indagato (colpevole o innocente che sia) è veramente tutelata.
La confusione dei ruoli e delle funzioni tra il potere esecutivo e quello giudiziario è sempre pericolosa anche quando è motivata dalle più nobili intenzioni e diretta a realizzare gli obiettivi più importanti, quale quello di attuare la giustizia, magari nella maniera più efficiente possibile: sempre Montesquieu, parlando in generale afferma che l’unione in capo agli stessi soggetti, o (è importante notare questa sfumatura del suo pensiero) in capo a soggetti simili, di questi due poteri porterebbe il loro titolare o l’insieme dei loro titolari a possedere “la forza di un oppressore”. La giustizia penale, come tutte le attività umane dirette ad imporre coattivamente le proprie decisioni ai singoli presenta inevitabilmente molti aspetti negativi in tutti gli ordinamenti giuridici, compresi ovviamente quelli basati su una piena separazione dei poteri tra accusatore e giudice.
Negli stati però dove i due ruoli pubblici sono confusi e mescolati tra loro, come accade in maniera più o meno accentuata in tutti i sistemi europeo continentali – e in modo particolare in quello italiano dove la unione tra le due figure, comprese entrambe nella “magistratura” è molto accentuata e ogni loro ulteriore distinzione viene spesso considerata (paradossalmente dal punto di vista chi scrive) un attacco alla divisione dei poteri – il rischio concreto di una “oppressione” del cittadino indagato o imputato, cioè etimologicamente di uno “schiacciamento” della sua libertà di difendersi e di far valere le proprie ragioni su un piede di parità con l’accusa di fronte alle decisioni dei funzionari pubblici incaricati di gestire la giustizia penale, è una realtà che tocca molte, troppe persone, una realtà tipica di uno stato a liberalismo debole, che in casi estremi può diventare decisamente illiberale.
La riforma appena approvata prevede tutta una serie di regole lodevolmente dirette ad accorciare i tempi del processo penale, ad evitare che vengano iniziati giudizi sulla base di prove inconsistenti, e a ridurre in concreto le pene per i reati lievi (cosiddetti “bagatellari”), ma in assenza di una modifica della struttura e a monte della visione di fondo, cioè della visione “culturale” della giustizia penale e del rapporto tra accusa, difesa e giudice, esse sono destinate a rimanere simili a delle concessioni che il potere pubblico fa agli imputati meritevoli o a quelli più scaltri ma che non aumentano di nulla la scarsa libertà di cui gode il cittadino nell’ambito del processo penale. Una situazione di scarsa libertà che è il frutto della storia della cultura giuridica e politica italiana, di cui non sarebbe giusto chiedere conto all’ultima riforma, che quella storia si è limitata a confermare, ma che a parere di chi scrive è sempre bene mettere in evidenza tramite il confronto con quelle realtà nelle quali l’attività giudiziaria, pur con tutte le sue pecche, si ispira pienamente ai principi liberali e in particolare a quello della separazione e contrapposizione dei poteri, e di conseguenza tutela in misura decisamente maggiore la posizione del cittadino nei confronti dei soggetti pubblici.